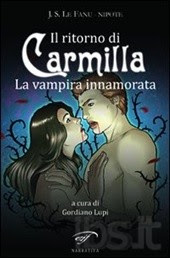Rendo pubblica una delle tante mie recensioni che saranno presenti nel mio primo volume dedicato allo spaghetti western. Questa è l'ultima recensione che pubblico sul blog, le restanti le recuperate all'interno del libro appena sarà disponibile (lo devo ancora ultimare).
PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
Produzione: Italia, Spagna, Germania 1966
Produttore: Alberto Grimaldi.
Regia: Sergio Leoene
Soggetto: Fernando Di Leo, Enzo Dell'Aquila
Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Enzo Dell'Aquila, Luciano Vincenzoni, Sergio Donati, Sergio Leone.
Interpreti Principali: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Mario Brega, Alfredo Sanchez Brell (Aldo Sambrell), Josef Egger, Peter Lee Lawrence, Mara Krup, Benito Stefanelli.Musiche: Ennio Morricone.
Durata 130 min.
Giudizio: *****
La trama
El Indio (Volonté), un bandito pazzo e drogato, evade dal carcere grazie all'aiuto della sua banda. Appena uscito uccide in un duello l'uomo che lo ha fatto arrestare, poi pianifica l'assalto alla banca più importante e sicura d'America: la banca di El Paso.Sulle sue tracce, intanto, si muovono due bounty killer: uno giovane e spavaldo (Eastwood), l'altro anziano e riflessivo (Van Cleef). I due finiscono per associarsi e stendono un piano: il più giovane opererà dall'interno della banda de El Indio, l'altro agirà dall'esterno. L'obiettivo è mettere le mani sia sulle taglie dei delinquenti sia sul malloppo che El Indio è riuscito a rapinare dalla banca.
Commento di MATTEO MANCINI
Qui si fa la storia dello spaghetti-western. Se “Per un pugno di dollari” aveva avuto un inatteso successo lo stesso non può dirsi per “Per qualche dollaro in più” sul quale tutti puntavano a occhi chiusi. Il film, tuttavia, ha un inizio più tribolato del precedente. Questa volta il problema non è il budget a disposizione, che anzi è cresciuto in modo esponenziale, ma le liti con i vari produttori. Oltre ai giapponesi della Toho Film (accusavano Leone di plagio, come abbiamo già visto) il regista romano deve vedersela con i suoi precedenti produttori (Papi & Colombo) che rivendicavano i diritti sulla figura dello “straniero senza nome”.
Sergio Leone però non si lascia frenare; si accorda con Alberto Grimaldi, già valido produttore di spaghetti-western e alla ricerca del film che gli potesse permettere quel salto di qualità che Marchent non era riuscito a garantirgli, e si lancia a capofitto nel lavoro.
La stesura del soggetto e della prima bozza della sceneggiatura viene affidata, in fretta e in furia per anticipare l'eventuale sequel che Papi & Colombo avrebbero potuto girare con un altro regista, al collaudato Fernando Di Leo, il quale contatta, quale suo collaboratore, Enzo Dell'Aquila. Dell'Aquila è un giovanissimo regista che cercherà di emergere negli anni '60, soprattutto in veste di sceneggiatore (suoi i copioni di spaghetti-western del calibro di “7 pistole per i MacGregor”, “Professionisti per un massacro” o “Sono Sartana il vostro becchino”) ultimando però la sua carriera nel 1969 senza lasciare una traccia particolarmente forte.
Ai due tocca il lavoro oscuro ovvero la stesura del soggetto e della prima bozza di sceneggiatura. Il lavoro è così ingrato che consegnato il copione (inizialmente intitolato “La collina degli stivali” e prima ancora “The bounty killer” - titoli che poi saranno utilizzati per altri western che nulla hanno a che fare con “Per qualche dollaro in più”) i due verranno costretti a suon di biglietti da centomila lire a rinunciare a ogni diritto sul film: i loro nomi non compariranno neppure nei titoli di testa!?
Il copione passa ora di mano e finisce in quelle di Luciano Vincenzoni, uno dei migliori sceneggiatori in circolo in Italia. Premiato per ben due volte con il Nastro d'argento per le sceneggiature di “Sedotta e abbandonata” (1964) e di “Signori e signore” (1965) entrambi film diretti da Pietro Germi, nonché autore degli script di capolavori quali “La grande guerra” (1959) di Mario Monicelli e della commedia “Crimen” (1960) di Mario Camerini, Vincenzoni si confronta per la prima volta col western con l'incarico di perfezionare il lavoro della già pregiata coppia Di Leo – Dell'Aquila. In seguito, l'autore trevigiano tornerà a firmare capisaldi del genere come “Il buono, il brutto, il cattivo” (1966) e “Giù la testa” (1971) di Sergio Leone, “Da uomo a uomo” (1967) di Giulio Petroni, ma anche altri celebri cult come “Piedone lo sbirro” (1973) di Steno o l'indimenticabile “L'orca assassina” (1977) di Michael Anderson ovvero le commedie brillanti “La poliziotta” (1974) di Steno, “Il bestione” (1974) di Sergio Corbucci e uno dei film più grotteschi mai realizzati in Italia, cioè “Gran bollito” (1977) di Mauro Bolognini.
Vincenzoni riscrive passo per passo la sceneggiatura, focalizzando l'attenzione sulla caratterizzazione dei personaggi, in modo particolare sull'antagonista di cui sceglie il nome “El Indio”.
Contemporaneamente, all'insaputa di Vincenzoni, un altro grande sceneggiatore lavora sul copione. Si tratta di Sergio Donati. Specializzato nei film carichi di suspence nonché già noto romanziere di polizieschi e noir all'americana, l'autore si confronta per la prima volta col western. Tornerà a trattarlo in capolavori quali “Faccia a faccia” (1967) di Sollima, "C'era una volta il west” (1968) e “Giù la testa” (1971) di Leone.Donati collaborerà inoltre con Vincenzoni in svariate altre occasioni (in film quali “Il bestione”, “La poliziotta”) e metterà la firma su copioni di film diventati autentici gioiellini della cinematografia italiana di genere come “Holocaust 2000” (1977) ovvero la risposta di Alberto De Martino al cult horror “Il presagio” di Richard Donner, “L'isola degli uomini pesce” (1979) di Sergio Martino e il thriller “Almost blue” (2000) di Alex Infascelli.
È proprio Donati a introdurre la simpaticissima sequenza del vecchietto, interpretato dal solito Josef Egger (il becchino de “Per qualche dollaro in più”), che rivela a Eastwood l'identità del vecchio bounty killer che gira in città. “Ma certo che lo conosco il tuo uomo. È il colonnello Douglas Mortimer, un gran uomo e un gran soldato. Il più formidabile tiratore della Carolina. Gran soldato, ora si è ridotto a fare il bounty killer come te, tutta colpa dei treni, degli stramaledetti treni.”
Inoltre, lo scrittore romano interviene massicciamente sui dialoghi (sua, a esempio, l'idea di far contare a Eastwood le vittime a fine film, facendogli conteggiare gli importi delle taglie piuttosto che il numero degli uomini caricati sul carretto).
Ne esce così una sceneggiatura filtrata da un lotto di signori sceneggiatori a cui si aggiunge l'estro di Leone che porta l'idea del carillon (elemento fortissimo e ricorrente nel film) nonché, su invito dell'aiuto regista (cioè quel Tonino Valerii che sarebbe presto sbocciato come eccellente regista di western), dell'antagonista drogato che fuma marijuana dopo aver commesso un omicidio.
Ecco che si giunge a un risultato finale che ha del portentoso. Non c'è infatti una sequenza che non rapisca l'attenzione dello spettatore. Dialoghi e monologhi fulminanti, battute e duelli intrisi di una spavalderia che non può non coinvolgere emotivamente e infine un trittico di soggetti l'uno più furbo dell'altro e posti in continua sfida tra loro.
La pellicola prende le mosse come potrebbe farlo un romanzo. Abbiamo infatti una divisione del copione in tre capitoli in ognuno dei quali vengono presentati i tre personaggi.
Il colonnello Douglas Mortimer viaggia su un treno leggendo la bibbia e tiene un cavallo in un vagone con una fuciliera appesa alla sella. Da essa estrae ogni specie di arma e prolunga atta a garantirgli una rosa di tiro superiore a quella convenzionale. “Come può fare il nostro mestiere uno che va in giro con una trappola come questa?” lo sfotterà in seguito Easwood. “Quella trappola, come la chiami, poteva spedirti nella fossa” sarà la risposta a bruciapelo del colonnello.
Il Colonnello è un uomo ragionevole, distinto, che veste in nero e mantiene la parola data ma che non ha nessuna pietà per i delinquenti. È subito emblematico, al riguardo, l'assassinio quasi gratuito del delinquente che ha l'abitudine di aggiungere uno zero sulla taglia affissa sui muri credendo che nessuno avrà mai il coraggio di affrontarlo.
Assistiamo in seguito all'arrivo, sotto un autentico nubifragio, de “Il monco”, cioè Clint Eastwood, così chiamato per l'abitudine di utilizzare un'impugnatura di cuoio per estrarre meglio la pistola.
Il nostro, probabilmente di ritorno dalla carneficina de “Per un pugno di dollari” (indossa difatti lo stesso poncho marrone), con fare sicuro e sprezzante, entra in un saloon e sfida a poker un ricercato che se ne sta spaparanzato a un tavolo sotto gli occhi di uno sceriffo colluso.“Cosa giocavamo?” gli chiede il delinquente dopo aver perso la mano. “La pelle!” è la laconica risposta del nostro che non perde occasione per far cantare la pistola non prima però di aver indotto gli altri a difendersi.
“Avete guadagnato una bella somma...” gli dirà lo sceriffo una volta pagata la taglia. “Già, ma uno sceriffo non dovrebbe esser coraggioso, leale e soprattutto onesto?” lo canzona il monco, togliendogli la stella dal petto e buttandola a terra davanti a dei cittadini: “cercatevene un altro” sentenzia.
Ecco il turno de El Indio, interpretato da un Gian Maria Volonté ancora più eccentrico e sopra le righe di quello ammirato in “Per un pugno di dollari”. Il nostro se ne sta in carcere per scontare una condanna ed è stato arrestato per mezzo di un tradimento. Aiutato dai compagni a evadere, El Indio non perde tempo per vendicare il torto subito e si mostra subito come un drogato esaltato e crudele (terribile la scena in cui fa assassinare la moglie e il bambino di un anno dell'uomo che l'aveva tradito: “possiamo dire che la tua famiglia, per metà, è anche mia e io me la prendo”), ma allo stesso tempo intelligente, ossessionato dal ricordo di una donna immortalata in un carillon che avvia in occasione di ogni duello per scandire il tempo al termine del quale estrarre le pistole.
È proprio l'evasione de El Indio a fungere da collante alle sorti dei tre, perché l'affissione della taglia dell'uomo porta sulle sue tracce i due temibili bounty killer che, in un primo tempo, si troveranno contrapposti l'uno all'altro.
Così assistiamo all'arrivo a El Paso del Monco che entra in un albergo e si prende la stanza dirimpettaia a quella in cui è alloggiato l'altro bounty killer. “Ma signore, la stanza è occupata...” gli dice il gestore. “Ora è libera” risponde con prepotenza il monco che prende il registro e depenna il nome del cliente. “Perché guardi quell'animale, che ci trovi?” domanda il gestore, un nano, alla sua donna, la tedesca Mara Krupp (la ritroveremo in “Satyricon” di Federico Fellini). “È un animale alto...” gli risponde la donna mandandolo su tutte le furie.
Intanto assistiamo ai progetti de El Indio che sta preparando un colpo folle: assaltare la più ricca e sicura banca di America, cioè la banca di El Paso. Per convincere i suoi, Volonté racconta la parabola del falegname e lo fa in un modo tale da rendere epico il momento.
Il colonnello Mortimer, nel frattempo, molto più scaltro del personaggio di Eastwood vaga da banca in banca per scoprire quale è la più sicura e a prova di rapina.“Solo a un pazzo potrebbe venire in mente l'idea di assaltare la banca di El Paso” è la sicura risposta di un banchiere alle domande del nostro. “Già, solo a un pazzo drogato” ridacchia Van Cleef, avendo già previsto tutto.
Per testare la propria idea, il colonnello Mortimer attende l'arrivo in città di alcuni componenti della banda de El Indio, quindi, spiato dal monco, entra nel saloon e va ad accendere un fiammifero sulla spalla dell'elemento più focoso del gruppo, il gobbo interpretato dal grande Klaus Kinski. Il bandito inizia a tremare preda di una rabbia isterica, fa per afferrare la pistola ma viene fermato da un compagno, il gigante Mario Brega, poi d'improvviso se ne va di gran carriera. “È molto strano” si rivolge il colonnello al barista “uno va in giro con la pistola e al momento di usarla non la usa”. “Se il gobbo non ti ha sparato è perché sotto c'è una ragione molto importante” risponde il barista, trovando il consenso del colonnello che ormai ha capito tutto. E infatti, dalla finestra della propria camera, inizia a studiare con un cannocchiale tutti i movimenti degli uomini de El Indio attorno alla banca di El Paso, infine si accorge di un imprevisto: c'è un giovane munito di binocolo che lo sta scrutando dall'albergo difronte. È una scena che sarà citata da altri western tra i quali “Vado, l'ammazzo e torno” di Castellari e che mette in comunicazione diretta i due protagonisti che iniziano a indagare l'uno sull'altro fino a misurarsi in un duello di precisione in cui sparano ai cappelli per cercare di impressionare l'altro e mandarlo in fuga.
Comica, al riguardo, la scenetta col cinese che va in su e in giù per la strada tenendo in mano le valige del colonnello e con Eastwood che gli ordina di portarle alla stazione e Van Cleef che invece gli dice di riportarle nella sua camera.
“Ragazzo, con i miei metodi sono arrivato a cinquanta anni e non sono pochi da queste parti. Tu quanto camperai?” domanda il colonnello al Monco una volta saliti nella camera del primo, ormai l'uno ammirato dalle capacità e dall'intraprendenza dell'altro. “Credo molto di più. Agguanto l'Indio, intasco i diecimila dollari, mi compro un buon ranch e mi ritiro” è la risposta guascona del Monco.
"Già, ma dimentichi un particolare: anche io voglio agguantare l'Indio e quando due reggimenti attaccano la stessa posizione finiscono inevitabilmente per spararsi addosso”. Il Monco, con la sua spavalda simpatia, aggiunge:“e il colonnello muore”.
Così i due si associano e predispongono un piano per agire sia dall'interno sia dall'esterno della bande dell'Indio e per farlo il Monco va a liberare un fedelissimo di quest'ultimo che se ne sta in carcere a scontare una pena. Il trucco è sufficiente al Monco per farlo accettare dall'Indio, ma i nostri stanno sottovalutando quest'ultimo.
“Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?” chiede il Monco che inizia a manifestare un certo senso di ammirazione nei confronti del collega più anziano. “Si, e anche incosciente come te fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa” risponde l'altro adombrandosi. “Quale? … forse è una domanda indiscreta” chiede il Monco, nell'osservare l'altro mentre tiene in mano un ciondolo. È un momento importante per il film, perché c'è uno snodo decisivo che inciderà sull'epilogo: viene lanciato un messaggio allo spettatore, perché quel ciondolo lega il colonnello all'Indio, si scoprirà poi la natura di quel legame.
Bellissima anche la risposta del colonnello alla curiosità del Monco: “le domande non sono mai indiscrete, le risposte, a volte, lo sono”. Momenti dunque di sceneggiatura che toccano delle vette difficilmente eguagliabili.
Il confronto tra le due generazioni di bounty killer prosegue con il giovane, più baldanzoso ed esuberante, che, dopo esser entrato nella banda dell'Indio, cercherà di scrollarsi di dosso l'ombra del vecchio colonnello, mettendolo sulla strada sbagliata, ma verrà ancora una volta sorpreso dalla furbizia dell'altro.“Come diavolo sei arrivato qui?” chiederà il Monco al colonnello, una volta entrato in un minuscolo paese della frontiera e trovandoselo inaspettatamente davanti. Il colonnello abbozzerà un mezzo sorriso e gli risponderà: “in base a un ragionamento. Sapevo che avresti detto all'Indio l'esatto contrario di quello che avevamo stabilito e che lui, sospettoso, avrebbe fatto di testa sua. Ho scartato l'ovest perché a ovest c'è El Paso, il resto è stato facile.”
Il confronto tra i due protagonisti non deve portare lo spettatore a sminuire l'intelligenza dell'antagonista. Il personaggio di Volonté è tutt'altro che sciocco, anzi è talmente convinto di sé da mettersi a giocare col fuoco, esponendo la sua banda alla mattanza.
“Nino, da quanto tempo sai che il Monco e quell'altro sono dei bounty killer?” domanderà a uno dei suoi uomini più fidati, ottenendo come risposta: “da questa notte, perché?” Allo stupore di Nino, l'immenso Volontè farà luccicare gli occhi: “Io l'ho saputo fin dal primo momento che li ho visti. Mi è venuta un'idea: usarli. Contro quei due credo che difficilmente qualcuno dei nostri sopravviverà, ma questo non interessa né me né te, perché noi due saremo già lontani con tutti i dollari”.
Ecco così che si entra nell'ultima parte del film, quella della resa dei conti. L'Indio ha orchestrato un'ottima messa in scena, dopo aver fatto aprire la cassaforte dal colonnello ha fatto imprigionare i due bounty killer per poi farli liberare da Nino simulando il tradimento di uno dei suoi uomini.
“Li voglio qui entro stasera!” urla come un pazzo, pronto ad abbandonare il paese con tutto il malloppo. “Groggy, ricorda, quei due piuttosto che averli alle spalle è meglio averli di fronte orizzontali, possibilmente freddi” si raccomanda falsamente a uno dei suoi.
L'Indio però ha fatto male i conti, perché i due pistoleri hanno già fatto sparire il bottino lasciando all'interno della cassa la pergamena con la foto dell'indio. Favolosa l'idea di immortalare nella foto da ricercato l'Indio mentre ride a squarciagola, perché quel volto contrasta nettamente con lo sguardo perso nel vuoto di Volonté che capisce di esser stato giocato dai due.
Bellissimo il duello finale, dopo che “i nostri”, in giro per il paese fantasma, hanno fatto fuori, uno a uno, tutti i componenti della banda dell'Indio. L'epicità dello scontro tra il colonnello Mortimer, intenzionato a consumare la sua vendetta – unica sua ragione di vita, visto che la morte di quella che si scoprirà esser stata sua sorella “gli ha reso la vita estremamente preziosa” così come dallo stesso rivelato al Monco al momento del loro primo accordo – viene esaltata da un escamotage che aggiunge un quid d'autore. L'Indio ha ormai in pugno il colonnello. Gli ha fatto cadere a terra la pistola e lo sta sfidando con il suo solito carillon: “Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare, cerca.” Proprio nel momento in cui il carillon sta per terminare la musica e il colonnello è ormai prossimo alla morte, visto il duello impari, ecco che riparte la musica, lasciando di sasso un Volonté sul punto di estrarre la pistola. Leone stacca dal primo piano di Volonté e riprende i due duellanti in campo lungo, quindi dal basso verso l'alto compare in primissimo piano una mano: tra le dita tiene un carillon, è quello che il colonnello Mortimer teneva nel taschino della giacca. “Sei stato poco attento, vecchio” dice il Monco, in una sorta di parabola dove l'allievo ha superato il maestro. “Colonnello, prova con questa. Tu, Indio, il gioco lo conosci” conclude puntando il winchester contro il messicano in una sorta di arbitro dell'incontro. Il passaggio della pistola dal Monco al colonnello si può interpretare come il passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione.
Notevole anche la conclusione del film, con il colonnello che rinuncia alla sua quota accontentandosi di aver ucciso l'uomo che gli ha rovinato la vita: “Ragazzo, sei diventato ricco. Tu solo, e te lo sei meritato” dice al monco che perplesso gli chiede lumi sulla loro società, ma il colonnello risponderà con un malinconico “un'altra volta” allontanandosi verso il tramonto e lasciando il nostro a contare i cadaveri dei delinquenti ammucchiati su un carretto.
Un western dunque leggendario che tutti hanno visto almeno una volta. Molto più complesso e deciso de “Per un pugno di dollari” e anche molto più crudo e cruento, non a caso ebbe vari problemi con la censura e soprattutto con i critici di alto borgo che lo accusarono di compiacenza verso la violenza, ma il successo al botteghino fu dirompente al punto da essere il film più visto nella storia del cinema italiano (tre miliardi e mezzo di incassi solo in Italia).
Nel ruolo di protagonista ritroviamo Clint Eastwood chiamato di nuovo a ricoprire il ruolo de “lo straniero senza nome”. Confermato in extremis anche Gian Maria Volonté, boicottato fino all'ultimo dai co-produttori spagnoli che non lo volevano per le sue idee politiche di estrema sinistra (al tempo in Spagna governava il regime di estrema destra di Francisco Franco). Alla fine Volonté riuscì a spuntarla solo perché Claudio Undari – attore di fiducia di Grimaldi – rinunciò al ruolo, schierandosi al fianco dell'attore milanese. Il suo è un ruolo simile a quello ricoperto in “Per un pugno di dollari” anche se più allucinato, soprattutto per merito degli onirici flashback inseriti da Leone impreziositi da una fotografia di una bizzarra tonalità rossa.
Fa invece il suo debutto nello spaghetti-western, e ne diverrà una delle icone più brillanti, il quarantunenne Lee Van Cleef. Fisico statuario, un metro e novanta di altezza per una struttura longilinea e un paio di baffi che lo accompagneranno quasi sempre nelle sue apparizioni cinematografiche e con un passato da ragioniere statale e da marinaio nella II guerra mondiale, l'attore americano si ritrova scritturato per mero caso a poche settimane dall'inizio delle riprese. La produzione, infatti, aveva già chiuso il contratto con Lee Marvin, uno dei “cattivi” più rinomati a Hollywood premiato nientemeno con l'oscar nel 1965 come attore protagonista del film “Cat Ballou”. L'attore newyorkese, infatti, rescisse d'improvviso il contratto con Grimaldi per poter girare il film che gli avrebbe permesso di conquistare l'oscar. Il forfait di Marvin è una notizia che mina l'entusiasmo del cast tecnico che si vede privato della sua star principale. Si cerca così di ripiegare su Henry Fonda ma ha un cachet insostenibile per la produzione. Alla fine qualcuno si ricorda di un attore che ha recitato spesso col ruolo di antagonista in importanti western americani come “Mezzogiorno di fuoco(Zinnemann, 1952), “Sfida all'O.K. Corral” (Sturges, 1957), “Bravados” (King, 1958) sebbene con ruoli secondari, ma si è anche distinto in film meno importanti nel ruolo di protagonista. Questo attore è Lee Van Cleef.
L'attore accetta senza tentennamenti, perché si trova a un punto morto della sua carriera tanto da vederne persino minata la sua prosecuzione. Sono infatti tre anni che non gira più un film, un terribile incidente automobilistico e la dipendenza dall'alcool hanno portato l'attore americano sull'orlo della capitolazione.
Le sue condizioni sono tanto preoccupanti che si pensa non possa neppure girare il film. Il nostro si presenta pieno di placche e chiodi, con un'andatura traballante e pieno di dolori. Il suo stato di forma è talmente fiacco che per salire in groppa a un cavallo deve utilizzare una scala. La scelta però si rivela quanto mai azzeccata. Il vecchio attore non sfigura al cospetto di due mostri sacri come Eastwood e Volonté e dona quel tocco malinconico che rende il film magnifico.
La sua performance è così convincente da renderlo uno degli attori più richiesti in Italia nel western, ma anche in altri generi con una carriera chi si protrarrà fino a un anno dalla sua morte. Lo si ricorda anche per l'interpretazione nel leggendario post-atomico di John Carpenter “1997 fuga da New York” (1981). Morirà nel 1989 in California vittima di un attacco cardiaco.
Con Van Cleef fa il debutto nello spaghetti-western un'altra indimenticabile icona: il polacco, naturalizzato tedesco, Klaus Kinski. Attore geniale e al contempo folle, spesso in lite con i registi, operatori e colleghi, capace di interpretazioni che lasciavano a bocca aperta come di immonde porcherie, presente in film di tutti i tipi dagli autoriali di Herzog agli sconclusionati deliri di Jess Franco il quale in un'intervista arriverà a dire: “Klaus Kinski era mezzo matto, dico mezzo perché era mio amico!” L'attore tenterà anche la via della regia nel provocatorio e delirante “Paganini” (1990) terminato di girare pochi mesi prima che sopraggiungesse la morte per improvviso attacco cardiaco.
Molte le sue interpretazioni memorabili specie nel western dove, a poco a poco, si ritaglierà ruoli sempre più importanti. In “Per qualche dollaro in più” ha un ruolo secondario, ma mette il suo volto al servizio di una scena epica in cui sfida a duello Van Cleef. “Guarda, guarda, chi si vede... Il fumatore” dice dopo averlo scorto mentre mangia seduto in un saloon. “Prova ad accendere un altro fiammifero” lo invita, mostrandogli la gobba. Favolosa la risposta del colonnello che lo manda su tutte le furie: “Abitualmente fumo dopo mangiato, perché non torni fra dieci minuti...”
Da notare in questa scena il tocco di classe in cabina di regia di Sergio Leone che fa sparare Van Cleef non con la pistola che tiene in bella evidenza sulla pancia, ma con una seconda, più piccola, nascosta sotto la giacca in modo da anticipare e sorprendere l'avversario. Trucchetti del genere faranno la fortuna del pistolero Sartana che Gianni Garko interpreterà nell'omonima serie.
Notevole anche il cast secondario con Luigi Pistilli, altro immenso attore di scuola teatrale lanciato da Sergio Leone (lo ricordo in svariati spaghetti-western e in film quali “Reazione a catena” di Mario Bava, “Milano calibro 9” di Fernando Di Leo e nei primi thriller di Sergio Martino), il coatto Mario Brega e persino un giovanissimo Peter Lee Lawrence, che qua fa un cammeo rapidissimo (è il ragazzo della sorella del colonnello che viene ucciso da Volonté nel flashback), e che in seguito ricoprirà ruoli da primo protagonista fino alla prematura scomparsa.
Sulla regia di Leone occorre spendere poche parole. Il maestro romano prosegue sulla strada tracciata nel suo primo western, con i molteplici duelli, i primissimi piani sui volti dei suoi eroi e con una certa dilatazione delle sequenze. Qua, per la prima volta, introduce i flashback per i quali nutriva un certo interesse come dimostreranno in modo marcato i successivi film.
Non poteva poi mancare Ennio Morricone alla colonna sonora, con una soundtrack che ricalca quella del film precedente e che tocca il suo apice nel duello finale (esiste anche una versione cantata in italiano).
Confermatissimi Massimo Dallamano alla fotografia e Carlo Simi alla scenografia.
Film epico da avere obbligatoriamente in videoteca.